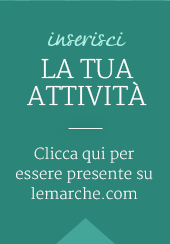Comune di Macerata
Piazza Libertà, 3 – 0733 2561
www.comune.macerata.it
comune.macerata@legalmail.it
Situata a 314 m d’alt. su un colle della dorsale che si eleva fra le valli del Potenza e del Chienti.
Sede di università e della scuola di specializzazione dell’Aeronautica militare. L’economia della città si basa sulla commercializzazione dei prodotti agricoli della zona circostante, costituendo il più importante mercato dei cereali dell’Italia centrale, con un certo peso anche per quanto riguarda il bestiame bovino. Lo sviluppo industriale è recente, ma presenta già imprese molto attive nei settori dell’edilizia, meccanico, alimentare e del mobilio. Notevoli sono le manifestazioni culturali e folcloristiche del settembre maceratese.
Patrimonio conservato nell’arco dei secoli:
La città conserva parte della cinta muraria del XIV sec., la porta Montana, la chiesa di Santa Maria della Porta, con chiesa inferiore dell’XI sec., e la Fonte Maggiore, a cinque arcate a pieno centro, del 1326. Nulla di notevole tra i monumenti superstiti del XV sec., mentre il primo cinquecento è testimoniato dall’elegante Loggia dei Mercanti, dal rimaneggiato Palazzo Maggiore (prefettura), dalla Torre Maggiore, e la metà del secolo dall’architettura, di impronta bramantesca, di Santa Maria delle Vergini, di Galeazzo da Carpi, a croce greca inscritta in un quadrato con alta cupola.
cinque arcate a pieno centro, del 1326. Nulla di notevole tra i monumenti superstiti del XV sec., mentre il primo cinquecento è testimoniato dall’elegante Loggia dei Mercanti, dal rimaneggiato Palazzo Maggiore (prefettura), dalla Torre Maggiore, e la metà del secolo dall’architettura, di impronta bramantesca, di Santa Maria delle Vergini, di Galeazzo da Carpi, a croce greca inscritta in un quadrato con alta cupola.
Dei secc. XVI-XVII sono pure alcuni notevoli palazzi: Ferri, Mozzi, Carradori, Lazzarini, Consalvi, gli ultimi due attribuiti al Tibaldi. Il Seicento è testimoniato dalla chiesa di San Giovanni e da quella di San Paolo, ambedue del barnabita Rosato Rosati, e dal Palazzo Comunale (rimaneggiato nel 1820).
Intensa l’attività architettonica settecentesca:
la chiesa di San Giorgio e il duomo, ambedue di Cosimo Morelli, col teatro (Bibiena-Morelli), coi palazzi Santafiora e Bonaccorsi, né va dimenticata la piccola basilica della  Madonna della Misericordia, incastrata tra edifici più recenti, risalente al 1497 ma completamente rifatta con equilibrata finezza, interno e facciata, da Luigi Vanvitelli (1742).
Madonna della Misericordia, incastrata tra edifici più recenti, risalente al 1497 ma completamente rifatta con equilibrata finezza, interno e facciata, da Luigi Vanvitelli (1742).
Il XIX sec. vanta lo sferisterio di Ireneo Aleandri, forse la più insigne realizzazione neoclassica dell’Italia centrale. Nell’ex collegio dei gesuiti hanno sede la Biblioteca, il Museo e la Pinacoteca comunale (dipinti di Allegretto Nuzi, Crivelli, Girolamo di Giovanni da Camerino, Pulzone).















 cinque arcate a pieno centro, del 1326. Nulla di notevole tra i monumenti superstiti del XV sec., mentre il primo cinquecento è testimoniato dall’elegante Loggia dei Mercanti, dal rimaneggiato Palazzo Maggiore (prefettura), dalla Torre Maggiore, e la metà del secolo dall’architettura, di impronta bramantesca, di Santa Maria delle Vergini, di Galeazzo da Carpi, a croce greca inscritta in un quadrato con alta cupola.
cinque arcate a pieno centro, del 1326. Nulla di notevole tra i monumenti superstiti del XV sec., mentre il primo cinquecento è testimoniato dall’elegante Loggia dei Mercanti, dal rimaneggiato Palazzo Maggiore (prefettura), dalla Torre Maggiore, e la metà del secolo dall’architettura, di impronta bramantesca, di Santa Maria delle Vergini, di Galeazzo da Carpi, a croce greca inscritta in un quadrato con alta cupola. Madonna della Misericordia, incastrata tra edifici più recenti, risalente al 1497 ma completamente rifatta con equilibrata finezza, interno e facciata, da Luigi Vanvitelli (1742).
Madonna della Misericordia, incastrata tra edifici più recenti, risalente al 1497 ma completamente rifatta con equilibrata finezza, interno e facciata, da Luigi Vanvitelli (1742). anto da essere compreso tra le civitates superiorem non cognoscentes: una sorta di piccolo stato sovrano, con diritto di battere moneta e di eleggersi, sin dal 1300, i propri ufficiali. Fu tra i primi comuni a pensare a un Monte di pietà e già dal 1447 si era dotato di suoi propri statuti. Con alterne vicende, nelle lotte di allora, si trovò ora con i Guelfi, ora con i Ghibellini. Più avanti appartenne allo Stato della Chiesa e quindi al regno d’Italia.
anto da essere compreso tra le civitates superiorem non cognoscentes: una sorta di piccolo stato sovrano, con diritto di battere moneta e di eleggersi, sin dal 1300, i propri ufficiali. Fu tra i primi comuni a pensare a un Monte di pietà e già dal 1447 si era dotato di suoi propri statuti. Con alterne vicende, nelle lotte di allora, si trovò ora con i Guelfi, ora con i Ghibellini. Più avanti appartenne allo Stato della Chiesa e quindi al regno d’Italia.

 P.zza Baldini, 1 – 0733 611131
P.zza Baldini, 1 – 0733 611131 della Vergine e Sant’Urbano I Papa con una maestosa cornice in legno intagliato e dorato. Conserva un prestigioso organo del veneziano Gaetano Callido, costruito nel 1771. La sacrestia, con mobili in legno del ‘700, è sede di una preziosa raccolta detta “Tesoro della Collegiata” e composta da quadri, busti di Santi in argento, paramenti e arredi sacri.
della Vergine e Sant’Urbano I Papa con una maestosa cornice in legno intagliato e dorato. Conserva un prestigioso organo del veneziano Gaetano Callido, costruito nel 1771. La sacrestia, con mobili in legno del ‘700, è sede di una preziosa raccolta detta “Tesoro della Collegiata” e composta da quadri, busti di Santi in argento, paramenti e arredi sacri. a, e di una zona più recente, distesa ai lati della strada principale. Il territorio comunale, solcato da vari corsi d’acqua, è caratterizzato dalle linee regolari dei campi coltivati, dei vigneti e dei prati adibiti al pascolo, tra i quali si snodano polverose strade sterrate; il paesaggio conserva l’impronta della tradizionale economia agricola marchigiana, che per secoli è stata sostenuta da una miriade di piccoli poderi mezzadrili destinati alle colture promiscue.
a, e di una zona più recente, distesa ai lati della strada principale. Il territorio comunale, solcato da vari corsi d’acqua, è caratterizzato dalle linee regolari dei campi coltivati, dei vigneti e dei prati adibiti al pascolo, tra i quali si snodano polverose strade sterrate; il paesaggio conserva l’impronta della tradizionale economia agricola marchigiana, che per secoli è stata sostenuta da una miriade di piccoli poderi mezzadrili destinati alle colture promiscue.


 Gualdo e San Ginesio ci furono lunghi periodi di contrasto, fino a quando nel 1484, per intervento del pontefice Sisto IV le due comunità firmarono una sentenza che fissava i confini al fiume Salino. L’importanza del castello di Gualdo fu anche determinata dal fatto che nel suo territorio passava il confine tra le diocesi di Camerino e Fermo.
Gualdo e San Ginesio ci furono lunghi periodi di contrasto, fino a quando nel 1484, per intervento del pontefice Sisto IV le due comunità firmarono una sentenza che fissava i confini al fiume Salino. L’importanza del castello di Gualdo fu anche determinata dal fatto che nel suo territorio passava il confine tra le diocesi di Camerino e Fermo.  agli Azzolini, dagli AMatori e dai Vittori di Fermo, fu ricostruita nei primi anni dell’800. Restaurata negli anni 40, si presenta in stile neo-classico-ionico, a croce greca. All’interno un bel quadro attribuito al De Magistris e un bassorilievo in pietra del ‘600.
agli Azzolini, dagli AMatori e dai Vittori di Fermo, fu ricostruita nei primi anni dell’800. Restaurata negli anni 40, si presenta in stile neo-classico-ionico, a croce greca. All’interno un bel quadro attribuito al De Magistris e un bassorilievo in pietra del ‘600.

 rizzato dalle antichissime botteghe per la fabbricazione della carta. Fu anche presidio fortificato del Ducato di Camerino durante la Signoria dei Da Varano, da questi passò allo Stato pontificio e ne seguì le sorti.
rizzato dalle antichissime botteghe per la fabbricazione della carta. Fu anche presidio fortificato del Ducato di Camerino durante la Signoria dei Da Varano, da questi passò allo Stato pontificio e ne seguì le sorti.